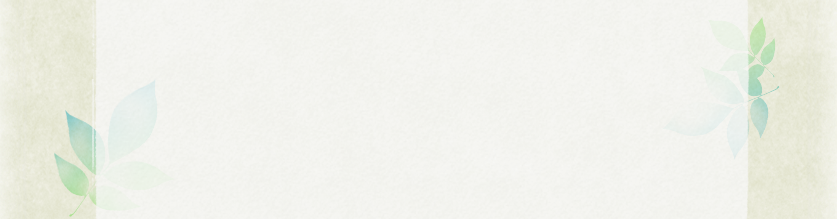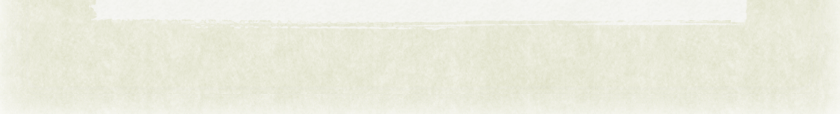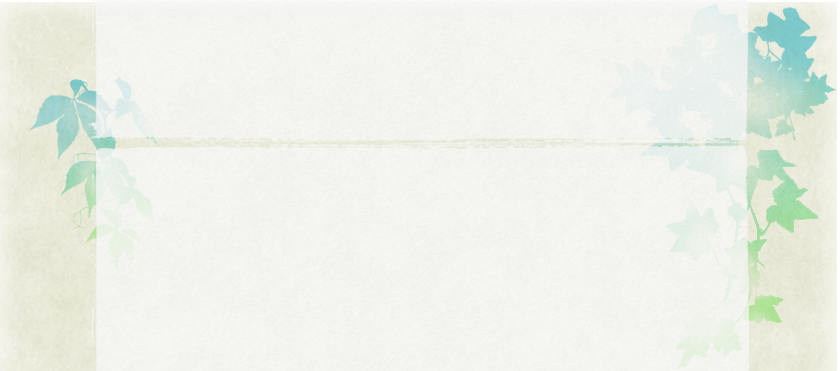

Nonostante i capostipiti dei palazzi fiorentini <<alla moderna>> siano senza dubbio Palazzo Medici e Palazzo Ruscellai è con Palazzo Pitti che la nuova tipologia quattrocentesca si precisa ulteriormente. Contrariamente ai precedenti due, infatti, che sono dislocati nel cuore della Firenze medioevale, esso viene edificato in Oltràrno, una zona periferica al di là del fiume, fino ad allora abitata solo dalle classi più povere. In tal modo il grandioso edificio va a costituire un nuovo e importante elemento di interesse urbanistico lungo la via che conduce a Porta San Pier Gattolini (oggi Romana) e, al di là di essa, verso il ricco contado del chianti.
Voluto da Luca Pitti (1395-1472), rappresentante di una delle più potenti famiglie fiorentine dell’epoca, il palazzo fu costruito a partire dal 1457, al centro di quello che il Vasari definisce con accento poetico <<il quasi teatro che fanno l’amenissime colline che sono intorno>>.Circa la paternità della costruzione il dibattito attributivo è ancora lungi dall’essersi concluso. Se la tradizione riferisce di un probabile progetto di Filippo Brunelleschi, è stato autorevolmente proposto anche il nome di Leon Battista Alberti.
Originariamente Palazzo Pitti nasce come edificio di forma pressochè cubica, con una facciata sulla piazza che comprende solo due ordini di sette finestre ciascuno. Le dimensioni di questa prima facciata (36 metri di altezza per circa 55 di lunghezza) dovettero apparire veramente straordinarie se ancora nel secolo successivo Niccolò Machiavelli osservava che il palazzo era <<al tutto maggiore che alcuno altro che da privato cittadino infino a quel giorno fosse stato edificato>>. La grandiosa sistemazione attuale, infine, con il fantasioso cortile cinquecentesco di Bartolomeo Ammannati e le nuove ali anteriori e laterali, deriva da oltre quattro secoli di quasi ininterrotti rimaneggiamenti e ampliamenti.
Tutti gli elementi della facciata sono in reciproca relazione dimensionale. Se prendiamo come modulo (cioè come base di misurazione) la luce (cioè la larghezza) del portale centrale al piano terreno vedremo, ad esempio, che la sua altezza è esattamente il doppio della luce. Ma anche le finestre dei piani primo e secondo hanno luce e altezza uguale alla loro luce. Ogni piano,infine, misura tre volte la luce delle finestre, mentre le ghiere in pietra che coronano gli archi a tutto sesto delle finestre sono larghe esatamente la metà della loro luce.
Questa complessa intelaiatura geometrico-proporzionale è ulteriormente scandita dalla diversa bugnatura del piano terreno ( molto rustica e pronunciata, quasi si trattasse di informi frammenti di roccia) rispetto a quella dei due piani superiori (assai più sagomata e meno sporgente).
A ciò si aggiunga la presenza di cornici marcapiano così aggettanti da configurarsi quasi come degli stretti ballatoi. La facciata della <<muraglia antica>> assume così un’imponenza ciclopica, comunque ammorbidita e nobilitata da una misura e da un’equilibrio mai prima sperimentati. Nel cortile interno l’Ammannati fa un uso spregiudicato degli ordini architettonici. In adesione alle tendenze manieristiche, infatti, le semi colonne dei tre piani sono fasciate da ricorsi di bugne che su esse plasticamente si sagomano.
Tuttavia, l’edificio rimane sostanzialmente estraneo alla città e al suo tessuto edilizio. Una sorta di gigante di pietra accovacciato ai piedi della dolce collina di Bòboli.